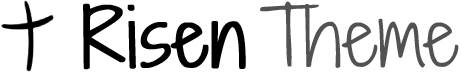La sezione femminile del carcere di Vercelli era composta di due cameroni che si aprivano l’uno nell’altro e che erano situati in un vetusto edificio male illuminato da un finestrino munito d’inferriate che ogni sera venivano percosse da un secondino allo scopo di constatarne – dal suono – l’integrità. Sul primo dei due cameroni si apriva una breve e minuscola scala di mattoni che immetteva in una stanzetta identica, salvo che nelle dimensioni, alle due grandi celle. Era l’abitazione della guardiana, la Margherita. La Margherita aveva una parrucca ed un gatto neri ed era sorda come una campana. Viveva detenuta come noi, con noi: debbo a lei se quel carcere vercellese non mi parve un carcere. Qualcuno all’ospedale deve averle dato una mancia – oppure era il mio prestigio di medico fino ad allora irreprensibile – ma ogni tanto mi faceva cospirativamente andare in “casa sua” e mi offriva una tazza di caffè di cicoria. In tempi di guerra non c’era altro.
I due stanzoni erano quasi pieni. Non ricordo se ci fossero delle detenute comuni, ma suppongo di no: in ogni caso, i miei ricordi mi rappresentano un gruppo in penombra di donne, capaci di una solidarietà quale io non avrei potuto immaginare, schiacciate dal guaio di essere lontane dalla famiglia che aveva bisogno di loro. Erano tutte contadine della risaia ed erano detenute per “favoreggiamento ai ribelli”. Lamentandosi con me delle loro pene, mi chiedevano se pensavo davvero che fosse stato stato possibile respingere qualcuno che non sapeva, non aveva dove andare in pieno inverno e che per questo aveva chiesto asilo. Ce n’erano che avevano figli o i mariti soldato, senza nemmeno sapere dove erano rimasti. Insomma, a Vercelli stare in prigione era come stare fuori: tutto era uguale. Non venni mai più interrogata e dopo alcune settimane mi chiedevo sempre più ansiosamente quale sarebbe stata la mia sorte. Era prigioniera dei fascisti? Lo ero dei tedeschi? Come potevano supporre la storia inventata della mia partecipazione alla liberazione dei prigionieri di guerra? Quasi quasi mi rincresceva che, dato lo stato delle cose, non lo avessi fatto per davvero.
L’unica vera angoscia erano i miei genitori, giacché essi vivevano a Fossano ed immaginavo come avessero reagito. Per mia madre, il carcere era una macchia indelebile; avevo paura che si ammalasse o morisse di crepacuore.
(Tratto da Monica Schettino (a cura di), Una storia non ancora finita. Memorie di Anna Marengo”, Varallo, 2014, p. 70)
Leggi la Biografia di Anna