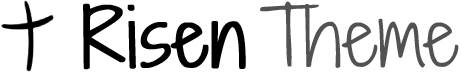Agli occhi dei tedeschi e dei fascisti le donne apparivano meno sospettabili, quindi erano più libere di muoversi da una zona all’altra. Per questo venivano spesso incaricate di portare ordini per lettera.
Così anche quella volta che scendemmo, Ines ed io, alla stazione di Mongrando, capolinea del tram di Biella, per dirigerci verso Bornasco, una frazione di Sala Biellese, avevamo da portare una lettera al comando partigiano della zona.
Pochissimi e frettolosi i passeggeri: in un attimo la stazioncina, che mi ricordava quella del mio paese, è deserta.
Tutto è tranquillo, anzi troppo tranquillo.
Per la strada che attraversa il paese non incontriamo anima viva. Di solito, nei piccoli centri, la gente si conosce tutta e quando esce e ci si incontra, è normale fermarsi e scambiare qualche parola. Invece non c’è nessuno agli angoli della strada, nessuno nei cortili aperti sulle vie, o davanti ai negozi.
Tutto questo avrebbe dovuto metterci in guardia. Invece procedevamo senza fretta e la nostra mente non percepiva nessun pericolo. Di solito eravamo attente al minimo cambiamento, i nostri sensi erano sempre all’erta. Quel giorno, no.
All’ultima curva, lungo il breve rettilineo dove terminano le case, prima del ponte, vediamo avanzare su due file i fascisti della Pontida. Sembrano lunghe schiere di formiche nelle loro scure divise. In mezzo a loro c’è un carro agricolo, trainato da un cavallo. Su di esso, coperti da un lenzuolo macchiato di sangue, dei morti.
Anche se, per la distanza, non riusciamo a scorgere la divisa, ci rendiamo subito conto che si tratta di caduti fascisti. Se si fosse trattato di partigiani o di civili certamente non ne avrebbero portato via i cadaveri.
Guida la testa della colonna un capitano. Senza esitare ci avviciniamo a lui, chiedendogli se possiamo proseguire. Egli ci guarda ed evidentemente non deve nutrire alcun sospetto: “La battaglia è finita – dice – potete andare, non c’è più nessun pericolo”.
Ringraziamo e, cercando di non guardare il carro col suo funebre carico, proseguiamo per la nostra strada, sulla quale si snoda la lunga colonna di soldati armati. Così, per un lungo tratto, dobbiamo passare in mezzo alle due file e sentire i commenti volgari dei fascisti. Ma le frasi che escono dalle loro bocche non ci toccano minimamente. Quello che invece ci preoccupa è sapere che più avanti la strada è minata con esplosivo a strappo. Tutta la colonna ci è passata sopra senza accorgersene.
Imbocchiamo infine la strada che porta a Bornasco, pensando di essere ormai al sicuro. Ma la nostra illusione è di breve durata.
Un’altra colonna, e questa volta di Brigate Nere, sta venendo verso di noi. Inconfondibili per il lugubre elmetto dal teschio bianco inciso, i loro volti appaiono duri e contratti. Alla loro testa riconosciamo il famigerato tenente Montuori.
Era conosciuto in tutto il Biellese per la sua ferocia e per una lunga cicatrice su una guancia che gli deturpa il volto. Solo a guardarlo incuteva paura. Tuttavia noi speravamo di poter passare anche qui. Ma le nostre speranze furono subito deluse.
Appena ci vede, ci impone l’alt, poi comincia con le domande: “Dove siete dirette?”. “Perché andate proprio a Bornasco in questo momento”. “Chi conoscete a Bornasco?”.
A tutte le nostre risposte non crede assolutamente. Cerchiamo di convincerlo che stiamo andando solo a comprare delle mele, ma è inutile.
“Siete in arresto – conclude – e se non volete parlare, sappiate che a Biella i mezzi per farvi sputare tutto non ci mancano”.
La colonna, durante l’interrogatorio, si è fermata, stringendosi intorno a noi. La fuga è impossibile.
I fascisti si rimettono in marcia e noi due siamo nel mezzo, ben sorvegliate. Ogni tanto Ines e io ci guardiamo e forse gli stessi pensieri ci passano in mente.
Prima di tutto si tratta di resistere alle eventuali torture: non dobbiamo assolutamente parlare; poi c’è la lettera che custodisco in tasca.
Se fossi riuscita a metterla in bocca e ad ingoiarla non avrebbero avuto prove, non avendoci ancora perquisite. Bisognava attendere il momento buono.
Un altro pensiero preoccupato era rivolto ai nostri partigiani: il combattimento si era svolto, i segni li avevamo visti con i nostri occhi. Chissà se anche da parte nostra vi erano dei caduti.
Io pensavo con rabbia a come era stato facile cadere nelle loro mani. Il nostro compito era pericoloso proprio per questo. Quando dovevamo rientrare al comando, dopo qualche missione, non potevamo mai essere sicure di trovare via libera: mentre qualche ora prima tutto era tranquillo, di colpo si poteva incappare in un combattimento e trovarsi nei guai.
Più nei guai di così non non avremmo potuto essere.
Ogni tanto guardavamo di sfuggita il tenente, pensando a tutto ciò che si raccontava sul suo conto. A me pareva impossibile che un uomo potesse arrivare a tanta malvagità, a non rispettare più nessun valore umano, a lasciarsi trascinare da un odio bestiale verso i propri simili, fino alla tortura.
Alla parola tortura io penso che ogni uomo debba rabbrividire. Ora sarebbe toccata a noi due. Montuori l’aveva detto chiaro e netto. Mentre cammino, osservo gli alberi, il cielo sereno e limpido. Ma, stranamente, non si sentono canti di uccelli: pare che anch’essi abbiano paura degli uomini.
“Possibile che tutto sia perduto – mi dico – che non succeda niente?”
Mi scuoto al grido: “Attenzione, una mina!”
Vediamo allora un fuggi fuggi generale. In mezzo alla strada restiamo solo noi due e il tenente. A questo punto ci viene quasi da ridere: quelli che si reputano dei leoni scappano come conigli di fronte a una mina a strappo.
Nella confusione generale capisco che è venuto il momento di far scomparire la lettera. E’ un attimo. Con la mano in tasca riesco, con un rapido movimento, a sfilarla dalla busta, ad appallottolarla e a portarle alla bocca. Ingoiarla non è altrettanto semplice.
Anche se non era una vera e propria lettera, ma un foglio di velina con brevi ordini, la saliva doveva inumidire la carta prima di masticarla e inghiottirla. Finalmente ci riuscii.
Ora potevo sentirmi più tranquilla e in cuor mio benedicevo la paura dei fascisti e la mina preparata dai partigiani: anche se non era scoppiata, il suo lavoro l’aveva fatto.
Guardo il tenente: sfigurato dalla rabbia, impreca e bestemmia contro i propri uomini, comprendendo negli insulti anche noi.
“Pagherete anche questa”, dice.
Mogi mogi, quei baldi fascisti ritornano sul posto all’ordine di far saltare la mina. Ci allontaniamo tutti, comprese noi due sotto stretta sorveglianza, poi c’è lo scoppio.
Riprendiamo così il cammino verso Mongrando. Presto siamo in vicinanza delle case. Entrati in paese capiamo il perché di quel senso di abbandono avvertito prima.
Dove passavano i fascisti, la gente si richiudeva nelle case. I negozi erano chiusi, con le saracinesche abbassate, come per un funerale. Non un segno di vita attorno, tutto era silenzio. Sembrava quasi che la popolazione avesse abbandonato il paese. Ma chissà quanti dietro le persiane serrate osservavano il triste corteo, imprecando contro i fascisti.
Ci dirigiamo verso la stazione, ripercorrendo così la strada che abbiamo fatto prima da sole.
Evidentemente da Biella erano arrivati con il tram, perché meno pericoloso con le imboscate.
Ci spingono vicino ad un muretto fiancheggiante la stazione, sorvegliate a vista da due armati di mitra. Mentre siamo così piantonate, notiamo che in stazione sostano anche i militi della Pontida con il capitano che avevamo incontrato all’andata.
A volte le idee improvvise possono salvare una situazione disperata. Così è stato in quel momento per noi.
Facciamo un cenno all’ufficiale, il quale nel vederci ha un gesto di sorpresa. Viene verso di noi e quando ci è di fronte lo assaliamo indignate: “Per colpa sua siamo nei guai. Sì, abbiamo avuto da lei il permesso di proseguire; se ce lo negava, noi ci troveremmo in questa dannata situazione”.
Gli accenniamo anche della minaccia della tortura fattaci dal tenente della Brigata Nera, toccandolo nel suo amor proprio di ufficiale.
Forse in lui c’è ancora un pò di umanità, o forse la nostra forza di disperazione per salvarci ci fa apparire sincere o indifese: manda a chiamare il tenente e gli dice: “Hanno avuto da me il permesso di proseguire, perciò sono libere”.
Sentiamo l’altro rispondere con rabbia: “Capitano, secondo me queste due ragazze sono partigiane”.
Ribattiamo subito: “Se fosse vero quello che lei dice, ci saremmo trovate dove voi avete combattuto poco fa”.
Fortunatamente il capitano, forte del suo grado, taglia corto alle proteste del tenente e mantiene la sua decisione.
Durante il colloquio tra i due avevamo cercato di mantenere il sangue freddo anche se capivamo benissimo che in quel momento si stava decidendo la nostra sorte. La cosa che ci angosciava di più era che, se fossimo state arrestate, non avremmo più potuto aiutare i nostri compagni.
Ma ora eravamo di nuovo libere. Il cielo pareva di nuovo nostro e avremmo gridato e ballato per la gioia e il sollievo.
Invece, per non destare sospetti, decidiamo di prendere anche noi il tram per Biella. Mentre passeggiamo lungo la pensilina, sentiamo il loro commenti confusi e frammentari sul combattimento in cui sono incappati. Le frasi mozze non ci aiutano a comprendere ciò che è successo, anche se accrescono i nostri timori per la sorte dei partigiani.
Quando con un piede già sul predellino ci accingiamo a salire sul tram, ci giunge un ordine secco: “Giù, non potete salire, il tram è riservato a noi”.
Dobbiamo attendere il prossimo. Ritornate sulla banchina della stazione, vediamo il tram allontanarsi pian piano, aumentare di velocità e infine scomparire alla prima curva, fra il verde della vegetazione con sul carico nero.
I minuti passavano lentamente: ancora stordite per quanto ci era accaduto, faticavamo a decidere il da farsi. Andare al comando era ormai assurdo e inutile, dato che la lettera non esisteva più. Ci conveniva tornare al comando zona per riferire l’accaduto e riprendere ordini.
Decidiamo di attendere il prossimo tram. Non è trascorso un quarto d’ora da quando abbiamo visto partire i fascisti, e ci giunge distinta, in lontananza, l’eco di una fitta sparatoria. Non riusciamo a capire cosa stia succedendo. I colpi si susseguono con violenza. In fretta ci portiamo sulla strada comunale che conduce a Biella per chiedere spiegazioni al primo arrivato, ma non viene nessuno.
Solo più tardi sentiamo l’urlo delle sirene: sono autoambulanze.
Intanto la gente esce per la strada come le formiche dopo un temporale; si formano capannelli dove ci si chiede se per caso non sia deragliato il tram. Finalmente vediamo giungere un uomo in bicicletta che pedala velocemente. Tutti gli siamo intorno. “I partigiani hanno attaccato il tram – dice trafelato – vi sono tanti morti e feriti”.
Sentiamo un sudore freddo scendere lungo la schiena, mentre il tremore ci impedisce di parlare, ma non di pensare.
Anche noi avremmo potuto essere su quel tram maledetto e non sarebbe stato giusto morire sotto la raffica di un nostro amico o compagno partigiano. Ancora una volta la fortuna ci era stata amica.
I fatti si chiarirono meglio il giorno dopo.
Il mattino presto, quando giungiamo al comando, il primo commento è: “Eccole qui, per un pelo non vi abbiamo sparato contro”.
Ci dicono che avevano saputo del nostro arresto; un nostro informatore ci ha visto passare sotto scorta fascista per Mongrando. Appena gli è stato possibile, è corso al Comando per avvertire i compagni della nostra cattura. Ma il distaccamento inviato per tendere l’imboscata al tram era già arrivato sul posto e non si poteva più fare in tempo a bloccare l’azione. I partigiani potevano solo sperare che noi, in qualche modo, fossimo riuscite a salvarci.
(Tratto da Cesarina Bracco, La staffetta garibaldina, Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Vercelli, Borgosesia, 1976, pp. 40-46)
Ascolta la lettura sulla web radio del progetto (clicca qui)!
Leggi la Biografia di Cesarina